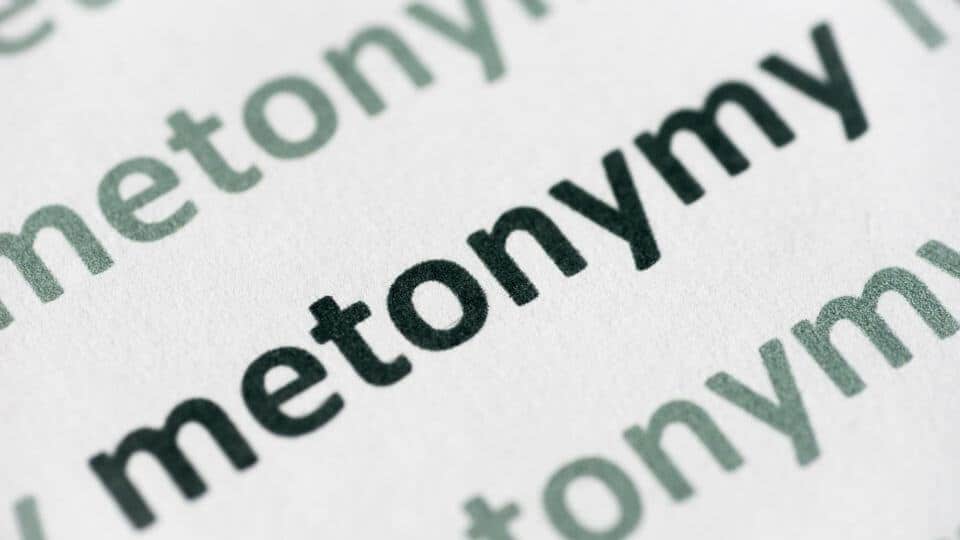Metonimia: significato ed esempi
Tra le figure retoriche la metonimia non è la più conosciuta. Forse per il nome poco orecchiabile, siamo più abituati a pensare a metafore e similitudini dimenticandoci che ne esistono molte altre. Sineddoche, sinestesia, ossimoro…la poesia (ma anche la prosa) è molto variegata e chi legge molto lo sa bene.
Spesso usiamo figure retoriche anche nel linguaggio di tutti i giorni. Sarà così anche in questo caso?
La metonimia: significato
La parola metonimia deriva dal greco ed è composta dall’unione di due parole. La prima è μετά, che significa “tramite”, “attraverso” e ὄνομα, ossia “nome”. Si tratta infatti di utilizzare un nome per indicarne un altro, uno scambio fra due termini che hanno una relazione fra loro.
Ricorda molto la sineddoche con una sostanziale differenza: non si tratta di un rapporto di quantità fra i termini bensì di una relazione qualitativa.
La sineddoche ad esempio utilizza parte di un oggetto per indicarne il totale, o il singolare per il plurale. Quando si dice le facce per indicare la gente o i tetti della città per indicare gli edifici. Un altro caso di sineddoche è il generale per lo specifico, come il felino per parlare di un gatto o di una tigre.
La metonimia invece guarda a un rapporto di causa-effetto fra le parole da scambiare.
Si tratta del nesso più comune ma si usa anche l’autore per l’opera da lui scritta o composta. Altri casi sono la materia per l’oggetto da essa ricavato, il contenente per il contenuto, ma è meglio vederli singolarmente.
Esempi emblematici e diffusi di metonimia
Vediamo di osservare le forme di metonimia più utilizzate. Alcune le abbiamo sempre in bocca senza saperlo, e le vedremo di seguito:
- Causa per l’effetto ed effetto per la causa. Sentire il cellulare (il suono di un messaggio o una telefonata) e alla famiglia manca il pane (manca il denaro, con cui si compra il cibo).
- Contenitore per il contenuto. Forse la più comune, soprattutto al bar con gli amici. Fatti un bicchiere (di vino, birra…), scolarsi una bottiglia (di bibita alcolica, spumante…). Ma anche per un’altra attività comune si usa dire fumare due pacchetti al giorno (di sigarette).
- Lo scrittore, pittore o compositore per l’opera da lui realizzata. Quando si parla di sculture o quadri famori si dice un Picasso, un Caravaggio…anziché indicare l’oggetto stesso. Così come tra musicisti si dice spesso suonerò Mozart/Bach per parlare delle sinfonie o dei concerti.
- Strumento per l’artista. Restando sempre in tema musicale, durante le prove orchestrali il direttore si riferisce ai violini, ai flauti…per indicare le sezioni. Ormai è un’abitudine così diffusa che nessuno vi fa più caso. Ma allo stesso modo parlando di uno scrittore emergente si dice una penna promettente. Altra metonimia radicata da sempre.
- Materia per l’oggetto. Quante volte per non ripetere quadri finiamo con il dire tele? Per quanto belli dopotutto è il materiale di cui sono fatti. Tremano i vetri per indicare le vibrazioni delle finestre, gli ori di famiglia in forma generica per i gioielli.
La metonimia, pertanto, è una figura retorica efficace che può aggiungere profondità e significato ai testi letterari, consentendo a chi scrive di creare connessioni e sottolineare concetti in modo più suggestivo e figurativo.
Alla base del rapporto di causa-effetto della metonimia c’è lo spostamento del significato di una parola o di un termine a un altro, all’interno dello stesso campo semantico e legati da un rapporto logico qualitativo, che può essere spaziale, temporale, causale o materiale.
In altre parole, la metonimia sostituisce una parola con un’altra che ha una relazione specifica con la prima, in modo che il significato originale sia riconoscibile ma enfatizzato o modificato attraverso questa sostituzione.
Casi più tecnici e meno poetici di metonimie
Quelle elencate finora sono le forme più comuni in cui ricorre questa figura retorica. Curiosamente anche nei campi meno letterari la metonimia si è fatta strada diventando parte integrante delle espressioni. Casi lampanti sono la Politica e l’Economia.
Un’espressione ricorrente nei notiziari e sui giornali è La Casa Bianca. Trattandosi dell’abitazione destinata ad uso del Presidente degli Stati Uniti d’America è chiaro cosa si voglia intendere. Però non ci si riferisce alla persona fisica bensì all’edificio che la rappresenta. Si usa quindi il simbolo per il suo significato concreto.
Non che in Italia siamo da meno. Il parere del Quirinale, la Magistratura…tutte figure retoriche che neppure consideriamo tali. Sappiamo naturalmente di parlare delle persone che ne fanno parte. Il messaggio però risulta più chiaro e diretto grazie a questa sfumatura della metonimia.
In campo economico il fenomeno è molto simile. Non di rado si sente parlare del triangolo industriale che poi sarebbe l’insieme delle città di Milano, Torino e Genova. Però gli esempi più lampanti sono riferibili ai brand, ai marchi più celebri.
Una metonimia canonica ad esempio è usare il marchio Rolex per parlare dei suoi orologi. Nessuno può fraintendere data la notorietà di questo bene di lusso quando si accenna ad un Rolex. Lo stesso avviene per tutti i produttori di macchine: ho una Renault, una Fiat, una BMW; si usa la casa produttrice per riferirci al singolo veicolo.
Dalle auto la faccenda si è allargata anche ai capi di abbigliamento più iconici: le scarpe! Ho comprato delle Timberland, mi serve un paio di Geox…e pure agli occhiali (Ray-ban).
Categorie individuate da un oggetto
Anche a livello lavorativo può capitare di imbattersi in questa figura retorica. Ogni attività viene identificata infatti con degli accessori o con dei capi di abbigliamento specifici. Non a caso si nominano le toghe quando si tratta di membri dell’ordine giudiziario. Oppure i camici bianchi quando in una struttura ospedaliera il personale vuole intendere i medici.
La metonimia legata al vestiario si presenta anche per le squadre sportive. La squadra italiana indossa lo stesso colore da una vita, da cui Gli Azzurri. Inter, Milan e Juventus vengono introdotte come i bianconeri, i rossoneri...e così via. In un certo senso questa figura passa così inosservata perché intuitiva e immediata al contrario di metafore e similitudini.
Anche le sedi fisiche possono arrivare ad indicare una categoria intera e non solo politicamente. Se non si hanno notizie di chi è ricoverato si dice che l’ospedale non ha dato notizie. In questo caso la sede di lavoro diventa l’insieme del personale che ci lavora. Lo stesso vale quando si nominano delle aziende per riferirsi agli operai delle stesse.
La differenza principale tra metonimia e sineddoche
La sineddoche è una figura retorica in cui una parte di qualcosa viene utilizzata per rappresentare l’intero o viceversa. Si tratta di una forma specifica di metonimia in cui la parte e il tutto sono strettamente legati e facilmente identificabili.
Esempio: “Ho bisogno di un paio di mani extra per completare questo lavoro“.
Qui, “un paio di mani” è una sineddoche in quanto una parte del corpo (le mani) rappresenta l’intero individuo. In altre parole, l’oratore sta chiedendo aiuto completo dall’individuo, ma usa solo una parte (le mani) per esprimerlo.
Mentre sia la metonimia che la sineddoche coinvolgono la sostituzione di un termine con un altro, la differenza principale tra loro è che la metonimia si basa su una relazione logica o di significato tra i due termini e può coinvolgere una varietà di sostituzioni, mentre la sineddoche è una forma specifica di metonimia in cui una parte rappresenta l’intero o viceversa.
Nel caso di sineddoche la relazione tra i termini è di tipo quantitativo: le parole sono legate da una logica del tipo “parte/tutto“, “singolare/plurale“, “genere/specie“. Entrambe le figure retoriche sono utilizzate per creare significato e dare enfasi nella scrittura e nella comunicazione figurativa.